Karl Marx parte 2: Critica a Hegel
 |
| Hegel e Marx |
- In questa seconda parte della mia rubrica su Marx introdurrò finalmente dei concetti filosofici e politici. Avendo finito con la biografia di Marx, tratteremo degli argomenti che sono alla base della politica marxista. Parleremo della critica al misticismo logico, al misticismo storico e al giustificazionismo di Hegel. Non spaventatevi se all'inizio sembrerà che io stia parlando di asini volanti, però per giungere a determinati concetti bisogna per forza comprenderne altri che si pongono alle fondamenta di tutto quello che andrò a spiegare. Non bisogna pensare che questi argomenti siano superflui, bensì sono solo propedeutici a quello che verrà in seguito. E' un po' come spiegare come funziona una tastiera ad una persona che dovrà utilizzare un computer, la parte più divertente inizia solo dopo. Suddividerò i punti dell’articolo in modo tale da fornire una lettura più semplice, e soprattutto per permettere una facile individuazione degli argomenti in caso si volesse rileggerli in un secondo momento. E’ innegabile il fatto che Marx abbia appreso lo storicismo e la visione dialettica della Storia da Hegel. Infatti, come spiegato nel precedente articolo, muove i suoi primi passi nella sinistra hegeliana, criticando però il suo maestro in alcuni punti chiave delle sue tesi…
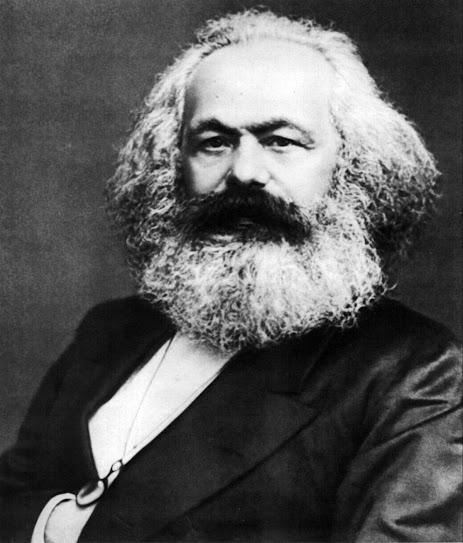 |
| La conoscenza del mondo è la premessa per cambiarlo ed essere rivoluzionari. Senza la teoria si sfocia nella ribellione, senza la pratica nell’idealismo |
1° Critica - Misticismo logico
Per capire il misticismo storico e il giustificazionismo bisogna capire il modo in cui Hegel ragiona, perché Marx prima di tutto imputa un errore metodologico al suo mentore. Non preoccupatevi, vi parlerò solo delle premesse del suo modo di pensare. Detta in breve:
“Per Hegel arriva prima la ragione, l’astratto, il pensiero, l’idea e solo dopo il mondo empirico e la concretezza”.
Vi faccio un esempio:
“Secondo Hegel nasce prima il concetto e l’idea di frutta nella realtà e poi in secondo luogo si riesce ad identificare questa idea nella realtà”.
Marx invece sottolinea il problema dovuto da questo metodo di pensiero, e controbatte dicendo che in realtà l’uomo invece ha prima di tutto un approccio empirico delle cose, prima osserva gli oggetti concreti: le banane, le mele, le pere, e solo dopo, per similitudine o un qualche altro tipo di logica, concepisce il concetto di frutta, costituito da quegli elementi osservati e analizzati.
Questo errore logico lo commisero Hegel, gli spiritualisti, i platonici e gli idealisti. Può sembrare strano, ma era abbastanza ricorrente incappare in questo modo di pensare che professava di far derivare la realtà dal pensiero. in conclusione possiamo dire che Marx differisce dalla visione di Hegel proprio dai principi e dai presupposti.
Una delle più grandi accuse che Marx rivolge ad Hegel è quella del misticismo storico (conseguenza del misticismo logico) ovvero la trasformazione ideologica della realtà. Possiamo dire in breve che Hegel mistifica logicamente il reale, ovvero la storia, e la trasforma in una manifestazione dell’idea, di quello che lui chiama: "l'assoluto" (intendo dire che piega la realtà secondo la sua ideologia). Hegel analizza la storia basandosi sulla sua chiave di lettura della realtà (misticismo logico), perché secondo lui la Storia è una manifestazione necessaria dello spirito, ovvero di una forza “divina” o una forza del bene (tale forza è l’assoluto), che guida l’umanità e la storia, che si evolve e che tenta di perfezionare le circostanze del mondo in cui essa vive per avviarsi verso il bene. Hegel afferma, citando la celebre frase: “Lo stato è Dio che entra nel mondo”. Questo significa che la Storia è guidata dall’assoluto e che allora in ogni periodo, avvenimento e situazione sociale è perfetta e come dovrebbe essere. L’assoluto guida tutto questo processo, nel bene e nel male, secondo un criterio che ritiene valido per realizzare un determinato scopo. Di conseguenza anche i momenti negativi sono perfetti, poiché momenti di passaggio e parte di un processo prestabilito e necessario che porterà l'umanità ad evolversi e ad arrivare ad un bene successivo.
Marx invece l'analizza come figlia di processi materiali, di cause concrete che si concatenano secondo un filo logico, la Storia è razionale e non irrazionale. Questo significa che Marx comprende che la Storia non è semplicemente dialettica, bensì dialettica materiale. Secondo lui funziona secondo delle precise forze che sono in contrapposizione, che variano lungo la Storia dell'uomo e che si possono individuare in base alla conoscenza umana del creato, dei rapporti sociali ed economici del periodo preso in analisi, ma non da una forza mistica e divina. Riconosce che la Storia funziona per contrasti e scontri, è quello che manda avanti la Storia e che ha permesso all'umanità di raggiungere determinati progressi.
3° Critica - Giustificazionismo
Il giustificazionismo invece è una diretta conseguenza del misticismo logico e già si intravede nel punto esposto precedentemente. Hegel per via della sua visione filosofica, ammettendo che il reale è prodotto dall'astratto, esiste essendo perfetto. Se tutto deriva dall'astratto, e l'astratto è perfetto, allora tutto il concreto è perfetto. Questo ragionamento non presenta contraddizioni nel metodo, ma come noi sappiamo nelle fondamenta. Questo ragionamento giustifica i momenti di trionfo per l'umanità, ma anche i momenti di miseria. Così si giustifica il passato e il presente e si diventa reazionari, in contrasto alle innovazioni. Marx, in contrapposizione, sottolinea che la Storia non è sempre perfetta e che si può cambiare, sia in male che in bene. Le istituzioni vigenti sono figlie della Storia di quel momento, possono cambiare e si possono cambiare innegabilmente in meglio.
Con questo ho finito di esporre, in sintesi, la critica ad Hegel di Marx. Pur non avendo trattato ancora dei veri e propri concetti appartenenti al comunismo, già possiamo intravedere l'impostazione con la quale Marx si rivolge alla società, ovvero il presupposto sul quale fonda la sua analisi sociale ed economica.
Gabriele Raschio
Commenti
Posta un commento